Vathek (1785)
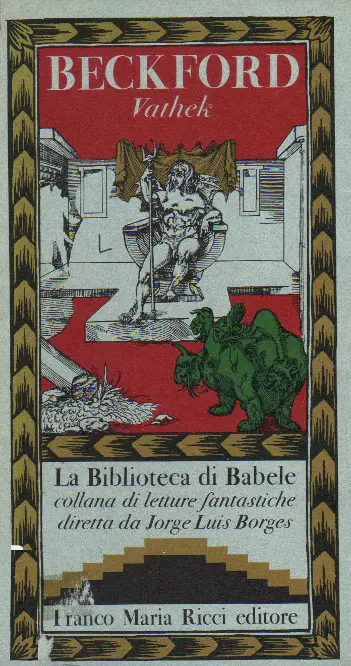
Vathek
di William Beckford
a cura di Jorge Luis Borges
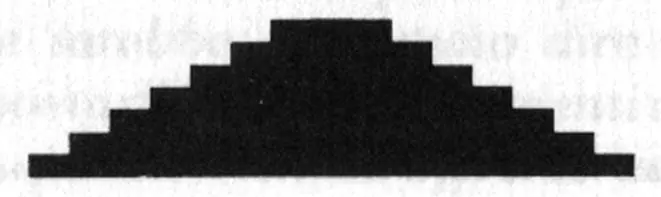
Titolo originale: Vathek
Traduzione di Giaime Pintor (Edizione LiberiPomi)
L'introduzione di Borges è stata tradotta da Gianni Guadalupi
Da qualche giorno passato con Borges a Buenos Aires, città labirintica e speculare, nacque in Ricci l’idea di questa Biblioteca di Babele, antologia in più volumi del fantastico da salvare, diretta, selezionata e introdotta dal grande scrittore argentino. Molte sorprese attendono il lettore: alle generose fonti orientali e ad autori mai tradotti in italiano si affiancano nomi già famosi riscoperti e “reinventati ” attraverso i mille riflessi degli specchi di Borges.
Introduzione
Qualche anno dopo il millenovecentotrenta, io ero primo assistente di una quasi segreta biblioteca nei sobborghi occidentali. Mi affidarono l'acquisizione di libri inglesi, che solo io avrei letto. Sfogliandoli ritrovai con meraviglia una sera della mia gioventù: la sera in cui lessi, in un altro sobborgo, il Vathek di Beckford (1760-1844). Essenzialmente l'intreccio di Vathek non è complesso. Vathek (Harùn Benalmotasim Vatiq Bilà, nono califfo abbaside) erige una torre babilonica per decifrare i pianeti. Questi gli predicono una successione di prodigi, il cui strumento sarà un uomo senza pari che verrà da una terra sconosciuta. Un mercante giunge alla capitale, dell'impero: il suo viso è cosi atroce che le guardie che lo conducono al cospetto del califfo avanzano a occhi chiusi. Il mercante vende una scimitarra al califfo; poi scompare. Incisi sulla lama vi sono misteriosi caratteri cangianti che beffano la curiosità di Vathek.
Un uomo (che poi scompare a sua volta) li decifra; un giorno significano: Siamo l'ultima delle meraviglie di una regione dove tutto è meraviglioso e degno del più gran principe della terra; e un altro: Sventura al temerario che vuole sapere quel che dovrebbe ignorare. Il califfo si dedica alle arti magiche; la voce del mercante, nell'oscurità, gli propone di abiurare la fede musulmana e di adorare i poteri delle tenebre. Se lo farà, gli verrà aperto VAlcàzar del Fuoco Sotterraneo. Sotto le sue volte potrà contemplare i tesori che gli promisero gli astri, i talismani che soggiogano il mondo, i diademi dei sultani preadamiti e di Suleiman Bendaùd. L'avido califfo si arrende; il mercante esige cinquanta sacrifici umani. Trascorrono molti anni sanguinosi; Vathek, l'anima nera di abominazione, giunge a una montagna deserta. La terra si apre; con terrore e speranza, Vathek scende fino in fondo al mondo. Una silenziosa e pallida moltitudine di persone che non si guardano erra per le superbe gallerie del palazzo infinito. Non gli ha mentito il mercante: l'Alcàzar del Fuoco Sotterraneo abbonda in splendori e talismani, ma è anche l'inferno. (Nella congenere storia del dottor Faust, e nelle molte leggende medievali che la prefigurarono, l'Inferno è il castigo del peccatore che patteggia con gli dei del Male; in questa è il castigo e la tentazione).
Saintsbury e Andrew Lang dichiarano o suggeriscono che l'Alcazar del Fuoco Sotterraneo è la maggior gloria di Beckford. Io affermo che si tratta del primo Inferno realmente atroce della letteratura. Arrischio questo paradosso: il più illustre degli averni letterari, il dolente regno della Commedia, non è un luogo atroce; è un luogo in cui avvengono fatti atroci. La distinzione è valida.
Stevenson (A Chapter on Dreamsj riferisce che nei sogni dell'infanzia lo perseguitava una sfumatura abominevole del colore bruno; Chesterton (The Man who was Thur-sday) immagina che ai confini occidentali del mondo forse esista un albero che già è più, e meno, di un albero, e ai confini orientali qualcosa, una torre, la cui sola architettura è perversa. Poe, in Manuscript Found in a Bottle, parla di un mare australe dove cresce il volume della nave come il corpo vivente del marinaio; Melville dedica molte pagine di Moby Dick a delucidare l'orrore della bianchezza insopportabile della balena... Ho prodigato esempi; forse sarebbe bastato osservare che l'Inferno dantesco magnifica la nozione di un carcere; quello di Beckford, i cunicoli di un incubo. La Divina Commedia è il libro più giustificabile e più fermo di tutte le letterature; Vathek è una mera curiosità, the perfume and suppliance of a minute; credo tuttavia che Vathek pronostichi, seppure in modo rudimentale, i satanici splendori di Thomas de Quincey e di Poe, di Charles Baudelaire e di Huysmans. C'è un intraducibile epiteto del dialetto scozzese, l'epiteto uncanny, per denotare l'orrore soprannaturale; questo epiteto (unheimlich in tedesco) è applicabile a certe pagine di Vathek,- che io ricordi, a nessun altro libro precedente.
Chapman indica alcuni libri che influirono su Beckford: la Bibliothèque Orientale di Barthélemy d'Herbelot; i Quatre Facardins di Hamilton; La Princesse de BabyIone di Voltaire; le sempre denigrate e ammirevoli Mille et une Nuit di Gallami. Io completerei questa lista con le Carceri d'invenzione di Piranesi; acque/orti lodate da Beckford che rappresentano poderosi palazzi, che sono anche labirinti inestricabili. Beckford, nel primo capitolo del Vathek, enumera cinque palazzi dedicati ai cinque sensi; Marino, nell'Adone, aveva già descritto cinque giardini analoghi. Del Marino ricordo sempre quella metafora dell'usignolo: sirena dei boschi. Solo tre giorni e due notti dell'inverno del 1782 impiegò William Beckford per redigere la tragica storia del califfo.
1 comment