Genius Loci
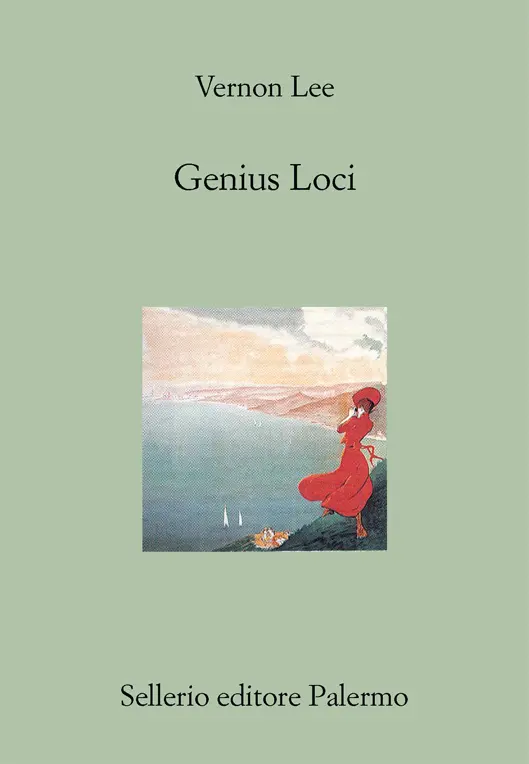
«Aveva piovuto a dirotto durante quell’ultimo giorno a Verona e il cielo aveva cominciato a schiarirsi solo nel pomeriggio. Comprai un mazzolino di lavanda per ricordo e prima di partire sorseggiai un caffè in Piazza dei Signori. Le pietre erano ancora bagnate, ma il cielo era ormai sereno. Umide nubi salpavano sopra le torri, i colombi torraioli beccavano sui marciapiedi e volavano dentro le fessure dei palazzi, le rondini emettevano strida mentre, nascosto dietro ai tetti, il sole stava tramontando».
Vernon Lee (pseudonimo di Violet Page, 1856-1935), scrittrice di saggi di critica estetica e di racconti di fantasmi – il suo capolavoro narrativo di cui questa casa editrice ha pubblicato Possessioni e L’avventura di Winthrop – residente dal 1889 alla morte a Firenze, seguace del Movimento Estetico di Walter Pater, apparteneva a quella generazione di viaggiatori sensibili, al pari dell’amico Henry James, alle inquietudini soprannaturali, spirituali, paganeggianti dei paesaggi soprattutto italiani, nei quali trovare vestigia e sopravvivenze degli antichi dei: spiriti dei luoghi di cui dare avvertenza a una classe di viaggiatori privilegiati e lenti, in resoconti di scrittura elegante e sottile malìa, come questi «paesaggi di trame e enigmi».
Il divano
254
DELLA STESSA AUTRICE
in questa collana
L’avventura di Winthrop
nella collana «La memoria»
Possessioni
Dionea e altre storie fantastiche
nella collana «Teatro»
Arianna a Mantova
Vernon Lee
Genius Loci
Lo spirito del luogo
Con una nota di
Attilio Brilli
Traduzione di
Simonetta Neri
Sellerio editore
Palermo
2007 © Sellerio editore via Siracusa 50 Palermo
e-mail: [email protected]
www.sellerio.it
Titolo originale: Genius Loci. Notes on places
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
EAN 978-88-389-2960-1
Paesaggi di trame e di enigmi
di
Attilio Brilli
Quando cominci a conoscere l’Europa gustandone i vini,
i formaggi e il carattere dei differenti paesi,
cominci a comprendere che dopo tutto il fattore
determinante di una cultura è lo spirito del luogo.
LAWRENCE DURRELL
C’è un atteggiamento ricorrente che porta molti scrittori inglesi e americani in viaggio attraverso l’Italia nella seconda metà del XIX secolo a cogliere nella natura, nel paesaggio, nelle città e talora nelle stesse persone una componente misteriosa, inquietante, elusiva, intimamente connessa all’idea che si ha della storia di questa civiltà. Non sono rari i luoghi nei quali è effettivo il rischio di imbattersi in forze arcane che stordiscono il visitatore con la loro presenza avendo condensato la memoria di un evento fatidico, o avendo coagulato il senso della storia che in quei luoghi ha effettuato una non effimera sosta. È con inebriato sbigottimento che, di passaggio lungo le rive del Trasimeno nel 1875, Henry James vi aspira «un’aura satura e dolcemente infestata, quasi che l’esperienza dei secoli si fosse disciolta in squisita soluzione». E quando cerca di dare una spiegazione a questa vaga ebrietudine ricorda che il lago è appunto il posto della famosa battaglia e che «non c’è pellegrino appassionato che muovendosi per questi luoghi in un afoso meriggio d’estate, non senta l’aria, la luce, il languore della brezza carichi di ossessivi fantasmi di quel ricordo». Da questo ricorrente approccio medianico ad una civiltà e ad un luogo è nato uno dei più suggestivi capitoli della letteratura di viaggio e della lettura dei luoghi. Ne è stata sollecitata in particolare la sensibilità dei forestieri che viaggiavano allora fra Francia, Italia e Germania, una sensibilità pronta a cogliere e ad indagare l’anima dei paesi e alla quale guardiamo oggi noi stessi con invidiosa ironia in un’epoca che appiattisce caratteri e differenze ambientali.
Allo spirito del luogo la scrittrice di lingua inglese e di formazione cosmopolita Vernon Lee ha dedicato varie raccolte di brevi saggi (pubblicati in prima battuta in rivista) composte con una continuità ed un ritmo sorprendenti fra lo spirare del XIX e il primo quarto del XX secolo, raccolte che hanno titoli affascinanti ed evocativi, vagamente ruskiniani: Limbo (1897), Genius Loci (1899), The Enchanted Woods (1905), The Spirit of Rome (1906), The Sentimental Traveller (1908), The Tower of Mirrors (1914), The Golden Keys (1925). Secondo il suo biografo Peter Gunn, questi saggi rappresentano l’epigono della tradizione degli Hazlitt e dei Lamb e si rivolgono a persone colte che amano viaggiare e che possono disporre con agio del proprio tempo. La schedatura è corretta ma del tutto insufficiente, perché questi brevi ma intensi saggi non sono affatto esemplari da sistemare una volta per sempre nello scaffale delle nostre collezioni private. Chi abbia la possibilità e l’agio di leggere almeno una di queste raccolte – e la presente versione italiana è l’occasione propizia – s’accorge che la pagina di Vernon Lee s’insinua come una sottile malia tra noi e il paesaggio che abbiamo occasionalmente sotto gli occhi e che il suo modo di interagire con il mondo circostante s’impone come un’inedita grammatica dello sguardo e dei sensi traducendosi in originali interpretazioni dei luoghi. Naturalmente la sua topografia emozionale, la sua occasionale hantise, i suoi esorcismi e le sue evocazioni sono, come si dice, figli del proprio tempo e come tali da collocare in una tradizione letteraria, estetica e di gusto relativamente circoscrivibili. Ma è appunto dopo aver compiuto quest’opera di contestualizzazione che prendiamo atto di una ridondanza magnetica che ci affascina e che sembra sprigionare aromi tanto più intensi, quanto più omogeneizzati si fanno i contorni ambientali entro i quali ci muoviamo.
Procediamo comunque per gradi e ricordiamoci innanzi tutto che il modo di porsi di Vernon Lee nei confronti del mondo circostante, fatto di paesaggi e di città storiche italiane, francesi, svizzere e tedesche, è lontano erede della tradizione romantica. L’impossibilità per i moderni di instaurare un approccio ingenuo, diretto e ritualmente salvifico con la natura, con le favole e con i miti degli antichi, dei quali la natura stessa è intessuta e dai quali deriva la propria identità, costituisce il dramma dolente inaugurato dalla stagione romantica. Da Schiller in poi, la concezione della natura non può che essere ironica e sentimentale, ed ogni colloquio con il paesaggio – il suo volto palese – tradursi in un atto riflessivo, consapevole della propria ricreazione immaginativa, della propria finzione. La realtà appare infatti all’uomo moderno come paradigma di un mondo dove ogni antica eco si è spenta per sempre e dove, per citare Coleridge, «gli oggetti come tali sono essenzialmente fissi e inanimati». La storia dell’eredità romantica è infatti la storia della rianimazione di questo universo che ora viene investito dei sentimenti e delle emozioni dell’uomo moderno, del poeta o dell’artista. Il pittore, sosteneva Friedrich, non deve dipingere solo quello che ha davanti a sé, ma anche quello che vede dentro di sé. Quando nella introduzione al proprio volume, Vernon Lee afferma che, come tutte le divinità degne di venerazione, il genius loci «ha la sostanza del nostro cuore e della nostra mente», non fa che investire i luoghi delle proprie emozioni e acquisire in proprio un’eredità che annovera fra l’altro, come ha scritto di lei Aldous Huxley, le «devozioni naturali» di Wordsworth e l’adorazione di una natura rivestita dei miti di una fanciullezza che si sa inesorabilmente perduta.
Ma è proprio vero che i luoghi si sono spogliati dei miti, che hanno visto scomparire le proprie divinità, che hanno perso l’anima per sempre? Se così fosse antiche città e paesaggi plasmati da civiltà secolari sussisterebbero sotto i nostri sguardi come singoli, inani, gelidi reperti. Non è forse vero invece che quelle antiche divinità si sono trasformate in creature differenti, in entità elusive e vagamente perturbanti? Il lettore dei racconti fantastici della nostra scrittrice sa bene che quei luoghi dove si svolge una qualche pratica consuetudinaria e rituale – la sabbia accecante, la chiesa ombrosa, la fumigante collina, la porta nella cinta muraria – sono altrettante soglie che propiziano un misterioso ritorno. Ma come può avvenire tutto questo in un luogo concreto e reale, in una città di cui si calcano concretamente le strade, in un paesaggio che si percorre con un qualche mezzo meccanico e all’apprezzamento del quale si vorrebbe introdurre il viaggiatore? È a questo punto che ci viene in soccorso un singolare libriccino, Gli dèi in esilio (1854) di Heinrich Heine, che ebbe un notevole ascendente su Vernon Lee, come lo ebbe su Walter Pater ed altri appassionati dell’Italia antica, e sul quale la nostra scrittrice avrebbe discusso a lungo nell’introduzione a For Maurice. Five Unlikely Stories (1927). Nello scritto di Heine si narra come il trionfo del cristianesimo abbia bandito le divinità pagane e le abbia costrette ad un’esistenza clandestina, incubica, tenebrosa e a scomparire e a riapparire senza requie sotto mentite spoglie. Seguiamo le parole di apertura del saggio di Heine: «Torno a parlare della trasformazione in demoni cui furono sottoposte le divinità greco-romane allorché il cristianesimo conquistò il predominio del mondo. La fede popolare attribuì allora a quegli dèi un’esistenza sì reale, eppure maledetta, concordando del tutto, in tale opinione, con la dottrina della Chiesa.
1 comment