Giulia o La Nuova Eloisa
Giulia d’Etange, figlia unica di una famiglia di nobili origini, ama il suo giovane precettore, Saint Preux, dotato delle più belle qualità dell’anima, ma povero e inferiore socialmente. Saint-Preux rappresenta per lei l’amore-passione.
Wolmar e quello che si usa dire un buon partito, uomo ricco e solido, amico del padre di Giulia, che promette alla figlia un legame coniugale senza rischi. A partire da questi personaggi, delineati con assoluta maestria, Rousseau costruisce un romanzo filosofico attraversato da un logorante interrogativo di fondo: e più giusto abbandonarsi alla pura passione amorosa, sacra espressione della natura e dunque inalienabile diritto dell’uomo, oppure tener conto delle convenzioni sociali, certo e solido fondamento della convivenza umana?
Di Jean-Jacques Rousseau (Ginevra 1712 – Ermenonville 1778) la BUR ha pubblicato: Confessioni, Il contratto sociale, Discorsi sulle scienze e sulle arti, Le fantasticherie del passeggiatore solitario.
Elena Pulcini insegna Filosofia sociale presso l’Università di Firenze. Tra le sue opere ricordiamo: Amour-passion e amore coniugale. Rousseau e l’origine di un conflitto moderno (1990) e L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e perdita del legame sociale (2001).
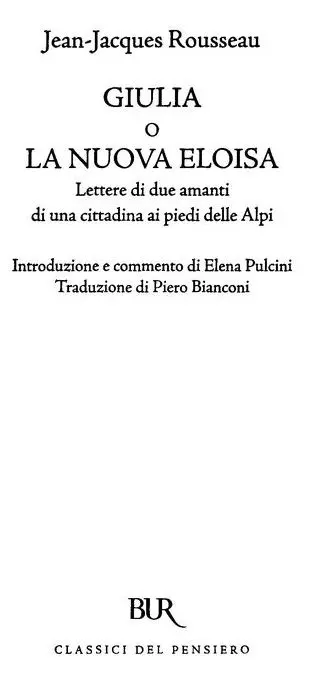
Proprietà letteraria riservata
© 1964, 1992 RCS Rizzoli Libri S.p.A.,Milano
© 1994 R.C.S. Libri & Grandi Opere S.p.A.,Milano
© 1998 RCS Libri S.p.A.,Milano
eISBN 978-88-58-63213-0
Titolo originale dell’opera:
Julie ou La Nouvelle Heloise.
Lettres de deux amants,
habitants d’une petite ville au pied des Alpes
Prima edizione digitale 2013
In copertina:
illustrazione Beppe Giacobbe
Progetto grafico Mucca Design
Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
INTRODUZIONE
Nota bibliografica
Per il testo originale della Nuova Eloisa e delle Opere di Rousseau si veda J.J. Rousseau, Oeuvres Complètes a cura di B. Gagnebin e M. Raymond, Gallimard, Pléiade, Paris 1959-1969, 4 voll.
Poiché non esiste un’edizione italiana delle Opere Complete di Rousseau, ho preferito trarre le citazioni dalla silloge attualmente ancora più completa di testi tradotti (sebbene la traduzione sia non sempre la migliore disponibile): J.J. Rousseau, Opere, a cura di P. Rossi, Sansoni, Firenze 1972 (d’ora in poi, semplicemente: Opere).
Per i testi non tradotti in questa raccolta, si rimanda di volta in volta, nelle note, alle altre edizioni disponibili.
Ho lasciato naturalmente il titolo originale per i testi di Rousseau non ancora tradotti in italiano.
Poiché nella traduzione si perde facilmente la pregnanza concettuale del linguaggio rousseauiano, mi è sembrato opportuno, ad ogni citazione, riportare in nota il testo originale, con il numero del volume delle Oeuvres Complètes e il numero di pagina (per esempio: OC, I, 45). Per questa stessa ragione, ho preferito mantenere il termine francese per alcuni concetti, in cui il termine italiano non rende la complessità semantica del termine originale: è il caso di bonheur (felicità), malheur (infelicità), faiblesse (debolezza), repos (riposo), ennui (noia).
Oltre alla letteratura critica riportata nelle note, ritengo necessario segnalare preliminarmente, per un’analisi capillare della Nuova Eloisa, due testi fondamentali:
D. Mornet, J.J. Rousseau et La Nouvelle Héloïse, Hachette, Paris 1925, 4 voll.
B. Guyon, Introduction e Notes et variantes, in J.J. Rousseau, Julie ou La Nouvelle Héloïse, nel già citato Oeuvres Completes, 1964, vol. II.
J. J. ROUSSEAU:
L’IMMAGINARIO E LA MORALE1
1. Genesi del romanzo: il percorso morale del soggetto amoroso
Nel soggiorno prescelto dell’Ermitage, dove approda nella primavera del 1756 libero di condurre la vita che più gli piace accanto all’affezionata Thérèse, Rousseau, come narra egli stesso nelle Confessioni, si sente preda di un crescente disagio. Egli avverte su di sé lo sguardo giudicante di coloro che già definisce la «coterie holbachique»2 cioè, oltre a d’Holbach, Grimm, Diderot, la stessa Mme d’Epinay sua ospite, con i quali in seguito si consumerà, come è noto, una violenta rottura. La solitudine, da lui amata in quanto sinonimo di libertà e autonomia individuale, mostra improvvisamente il suo lato oscuro e inquietante di minaccioso isolamento, in cui affiora un radicale, incolmabile sentimento di vuoto.3
Autore già celebre per il successo dei primi due Discorsi, Rousseau è nel pieno della sua attività intellettuale. Prende corpo in questa fase sia il progetto delle Institutions politiques che quello della Morale sensitive, cui egli spera di potersi dedicare, favorito da una vita intima appagante in un luogo amato, lontano dal frastuono alienante della città. Ma un’inattesa crisi viene a mettere in luce la delusione delle sue aspettative e l’impossibilità di rispettare i progetti accarezzati. La relazione affettiva con Thérèse non riesce a colmare il senso di solitudine che gli deriva dal distacco dagli altri uomini e dalla società. Di questo senso di abbandono, essa diviene, al contrario, la fonte principale, poiché non ha prodotto quell’«unione dei cuori» cui Jean Jacques ha sempre intensamente aspirato. Egli è colto allora da un’intensa nostalgia per il passato che, attraverso la figura mitica di Mme de Warens, rende più acuto il vuoto del presente e produce l’inquietante rivelazione di una mancanza. Attraverso un rapido bilancio della propria vita, Rousseau si accorge di non aver mai veramente soddisfatto il suo bisogno d’amore, reso tanto più urgente dalla percezione di sé come un uomo dal cuore avido e dai sensi «combustibili», da sempre alla ricerca di un oggetto che sappia offrire uno sbocco al «fuoco divorante» dell’ebbrezza amorosa.4 Alla rivelazione di questo sconcertante paradosso, si unisce l’implacabile consapevolezza del tempo che passa e di un’esistenza per metà trascorsa senza che sia stata data risposta al desiderio più radicale. «Divorato dal bisogno di amare, senza averlo mai potuto ben soddisfare – dice Rousseau nelle Confessioni – mi vedevo avvicinarmi alle porte della vecchiaia e morire senza aver vissuto.»5
La memoria continua a popolarsi delle figure femminili che hanno costellato la sua vita, facendo crescere lo stato di ebbrezza, fino a riattivare quella facoltà immaginativa che da sempre ha per Jean Jacques la funzione di compensare le insufficienze del reale:6 «Che cosa feci allora? [...] L’impossibilità di raggiungere gli esseri reali mi gettò nel paese delle chimere; e non vedendo niente di esistente che fosse degno del mio delirio, lo nutrii in un mondo ideale che la immaginazione creatrice popolò ben presto secondo il mio cuore».7 Il «gusto per gli oggetti immaginari», che nell’inquieta fase dell’adolescenza permetteva a Jean Jacques di placare le pressioni di una sensualità nascente e di evadere da una realtà insoddisfacente,8 riemerge con tale forza da resistere persino all’affollarsi di contrarietà quotidiane e di distrazioni intellettuali.9 Il suo «dolce e folle sognare» («douce et folle rêverie»),10 portatore, come annuncia egli stesso, di funeste conseguenze in quanto prelude all’infelice relazione con Sophie d’Houdetot, lo spinge dunque fino alla creazione immaginaria di esseri dotati di ogni perfezione, dei quali egli nutre le proprie estasi solitarie.
Qui prendono forma ed assumono consistenza i personaggi principali della Nuova Eloisa, proiezione fantastica del delirio amoroso, incarnazione pigmalionica di un desiderio che vuole alimentarsi dei propri fantasmi: «Mi raffigurai l’amore e l’amicizia, i due idoli del mio cuore, sotto le immagini più incantevoli: mi compiacqui ad ornarli di tutte le grazie della femminilità che avevo sempre adorato».
1 comment