Il piccolo Lord
Copertina
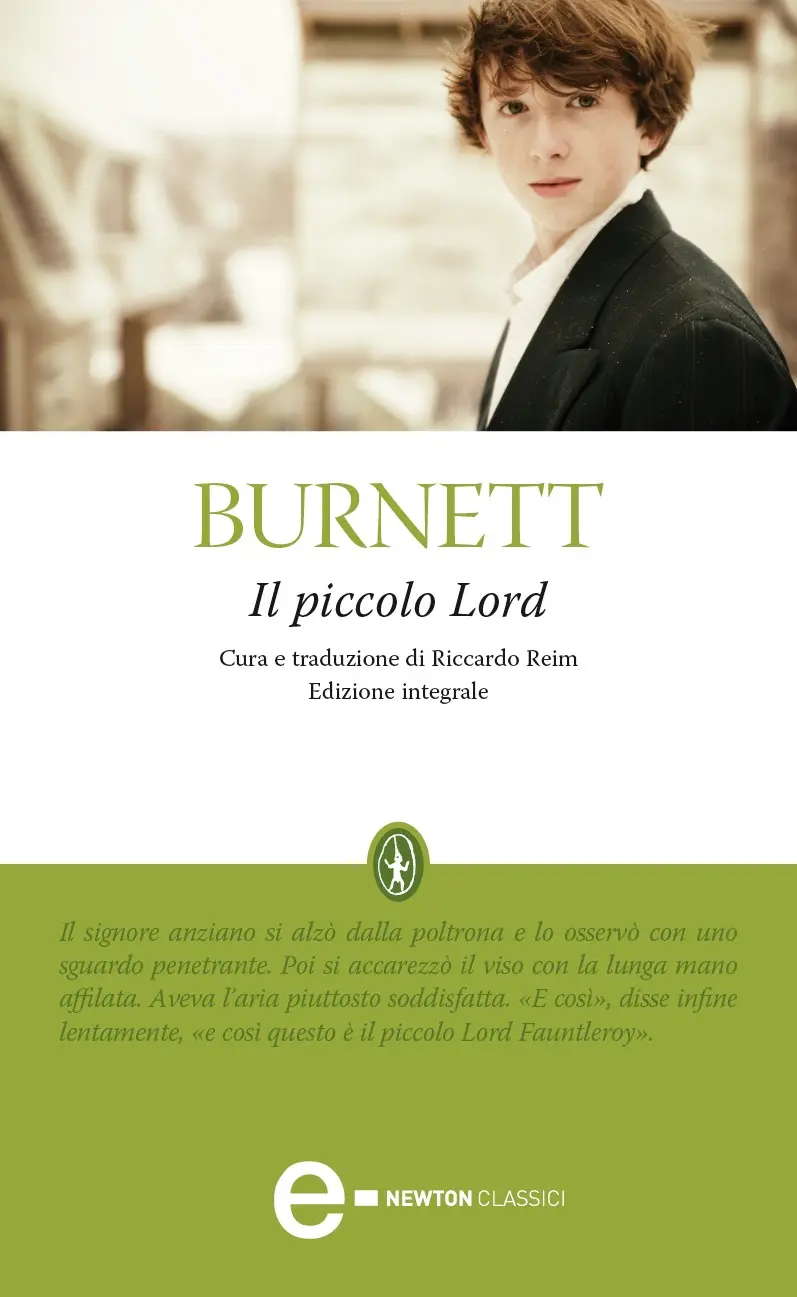
Collana

310
Colophon
Titolo originale: Little Lord Fauntleroy
Traduzione di Riccardo Reim
Prima edizione ebook: gennaio 2012
© 2012 Newton Compton editori s.r.l.
Roma, Casella postale 6214
ISBN 978-88-541-3857-5
www.newtoncompton.com
Edizione elettronica realizzata da Gag srl
Frontespizio
Frances Hodgson Burnett
Il piccolo Lord
A cura di Riccardo Reim

Newton Compton editori
L’innegabile fascino dei riccioli d’oro
Little Lord Fauntleroy, sesto romanzo di Frances Hodgson Burnett, inizia ad apparire a puntate sul «St. Nicholas Magazine» nel novembre 1885 – corredato dalle bellissime, innovative illustrazioni di Reginald Birch1 – per giungere nelle librerie pochi mesi dopo, immediatamente divorato (è davvero il caso di dirlo) da centinaia di migliaia di lettori (anzi lettrici: pensato come romanzo per bambini, il libro suscita un interesse quasi morboso soprattutto fra le madri) e raggiungendo in breve la vertiginosa tiratura di mezzo milione di copie. È finalmente il grande successo, la popolarità alla quale Frances aspira cocciutamente da quando, circa dieci anni prima, ha cominciato a pubblicare con una certa regolarità racconti e articoli su riviste come Godey’s Lady’s Book, Harper’s Bazaar, Peterson’s Ladies Magazine...: la bimba dagli occhi sognanti (così almeno lei stessa si descrive nell’autobiografia del 1893, One I knew the Best of All) immersa nell’affascinante mondo dei libri è divenuta negli anni una donna forte e volitiva, lavoratrice instancabile e sagace amministratrice di se stessa, meticolosamente dedita alla costruzione del personaggio che ha fermamente deciso di essere. Proprio con il successo di Little Lord Fauntleroy, infatti, Frances, attentissima ai meccanismi dell’industria editoriale americana, inizia a formare – e a pubblicizzare accortamente – la raffinata, preziosa, “charming” immagine della “Romantic Lady”, la futura «Princess of Maythan» (per citare la definizione non priva di ironia di Henry James)2 che vive e lavora in un’atmosfera di sogno circondata dall’amore dei suoi «adorati e adoranti» figli Lionel e Vivian...3 Sarà proprio quest’ultimo, nato il 9 aprile 1876, a fornire il modello per Cedric Errol, il piccolo americano erede dell’immensa fortuna di un vecchio nobile inglese: in una foto pubblicitaria del 1886 (realizzata in occasione della trasposizione del romanzo sui palcoscenici) eccolo apparire perfettamente abbigliato come il protagonista del libro, con tanto di morbidi riccioli biondi ricadenti sulle spalle, gran colletto di pizzo e scarpini alla Oscar Wilde (il quale poco tempo prima, nel suo tour di conferenze negli Stati Uniti, aveva onorato il salotto della scrittrice di una sua visita), leziosamente in posa nel celebre «flamboyant velvet pageboy costume» con il quale centinaia di madri americane vorranno di lì a poco infagottare i loro recalcitranti figli sognando di vederli meravigliosamente belli e inappuntabilmente educati come, evidently, devono essere i loro nobili e più antichi parenti europei dall’altra parte dell’Atlantico...
Il “piccolo Lord Fauntleroy”, dunque, esiste davvero, è possibile, concreto e tangibile: realtà e fantasia finiscono così, magicamente, per sovrapporsi e coincidere (espediente già usato più volte dal feuilleton e che anche il romanzo rosa, più tardi, farà proprio) creando nel lettore una sorta di spaesamento che favorisce una serie di fantasticherie e di proiezioni anche al di là della vicenda romanzesca: si potranno, ad esempio (la fotografia è lì, modello indiscutibile), formare tanti “piccoli Lord Fauntleroy” vestendo i ragazzi con quell’abito romantico e suggestivo, assaporando così anche in casa propria (e in fin dei conti piuttosto a buon mercato) certe delizie aristocratiche della vecchia Europa...
Due anni prima, la cultura americana aveva felicemente trovato la sua autonomia nella voce stridula e sgangherata, perentoria e petulante di Huck Finn, il piccolo vagabondo dall’inviolabile innocenza partorito dalla geniale fantasia di Mark Twain; qui, invece, nella fiaba-romanzo del bel bambino biondo e roseo ci si volta nostalgicamente – e con emozionata reverenza – verso l’originaria Albione (non va dimenticato che la Hodgson Burnett nasce a Manchester) con i suoi castelli, i suoi parchi, i suoi cerimoniali, le sue argenterie e le sue porcellane... Ecco dunque un vecchio e potente aristocratico inglese, un ricco, altero signore dell’epoca della Regina Vittoria, quando non si diceva Inghilterra, bensì Impero Britannico, un impero orgogliosamente basato sul culto indiscutibile della tradizione, dove nelle scuole, nelle chiese, nei locali pubblici, nelle ricorrenze festive, nelle abitudini alimentari si continuano a seguire usanze antichissime; dove i soldati portano da sempre le stesse divise e sventolano gli stessi stendardi suonando con le cornamuse le marce militari di un tempo; dove si prende il tè con le tartine imburrate vestiti di tutto punto e sempre at five o’clock sharp, anche in mezzo al deserto o nel cuore della giungla nera... Un impero, infine, dove ci sono questi parenti un po’ imbarazzanti e decisamente boorish, insomma i cosiddetti “cugini” americani, che il vecchio nobiluomo disprezza con tutto il cuore... Cugini?! Nel 1776 quei bifolchi avevano osato ribellarsi a Sua Maestà il Re d’Inghilterra – e ai suoi lord, ovviamente – creando una repubblica, si erano battuti gloriosamente contro le truppe inglesi dalle rutilanti divise rosse, loro, un esercito improvvisato di contadini, osti, mandriani, bottegai... loro, che avevano cominciato la rivoluzione gettando in mare tutte le casse di tè contenute nella stiva di una nave. Una specie di sfregio. Tipacci. Gentaglia poco raccomandabile, rabble. Altro che “cugini”, anche se parlano la stessa lingua. E anche su questo punto ci sarebbe parecchio da discutere: li avete mai sentiti aprire bocca? Da rabbrividire. Mandriani, per l’appunto, puzzolenti quanto i pellerossa: abituati a stare gomito a gomito con le vacche, a mangiare bistecche di bisonte, patate dolci e pannocchie di granturco, a masticare tabacco e a bere enormi cuccume di orrendo caffè...
Ed ecco, accade che una di loro, una yankee, per una serie di circostanze straordinarie sposi uno dei figli del vecchio aristocratico e che dalla loro unione nasca un bambino, presto orfano di padre, il quale, per altre circostanze ancor più straordinarie, si trovi di punto in bianco a essere l’unico erede dell’immenso patrimonio familiare... Può mai il nobile nonno lasciare il sangue del suo sangue in mezzo a degli zotici così? Naturalmente no: il ragazzo dovrà trasferirsi in Inghilterra per essere educato a dovere, come si conviene al suo rango, imparando nuove regole e dimenticando al più presto tutte le stupidaggini di cui gli avranno imbottito la testa laggiù negli Stati Uniti... Come andrà a finire? È presto detto: nonno e nipote, senza neppure troppe difficoltà, imparano subito a volersi bene, in quanto il vecchio Conte di Dorincourt rimane letteralmente conquistato (come tutti, del resto, compresa la servitù del castello) dalla bellezza, dalla simpatia e dai modi raffinati del bambino (il quale ha tutti i requisiti fisici e morali del principino), mentre quest’ultimo è talmente candido e sprovveduto (fino all’incredibile, ma non va dimenticato che ci troviamo in una sorta di fiaba) da non accorgersi mai, in alcun modo, del carattere dispotico ed egoista del nonno. Tanti buoni sentimenti, insomma, ma propinati dall’autrice con bel garbo e indubbia abilità, in una prosa sobria e scorrevole, tanto che Little Lord Fauntleroy è ancora oggi un evergreen tradotto in decine di lingue e presente in quasi tutte le collane di letteratura per ragazzi.
Si è voluto parlare, a proposito dell’attualità di questo romanzo, di «incontro-scontro tra due culture» (Antonio Faeti)4 , di «differenza», di «rispetto», di «confronto»... Ma è davvero un americano il piccolo Cedric Errol? In realtà è un “cugino” accettabile perché è assolutamente eccezionale, nelle origini come nell’educazione e nel fisico. È un inglese accidentalmente nato in America, e il suo pregio maggiore, a ben guardare, è proprio quello di essere sorprendentemente così poco “americano” nei modi (tranne il vezzo di tenere le mani in tasca) e nell’aspetto, come pure, del resto, nelle idee, a parte qualche infantile, generica affermazione sul Quattro Luglio e sull’illuminata generosità che i ricchi dovrebbero avere verso i poveri: cose accettabilissime e persino divertenti in una bella bestiolina ammaestrata che sa fare con garbo la riverenza e sedere a tavola compostamente. Lo scarruffato vagabondo Huck o il piccolo-borghese Tom Sawyer verrebbero bene accolti con altrettanta facilità? C’è da dubitarne: la loro voce nasale e la loro camminata dondolante non sono fatte per gli antichi castelli d’Inghilterra, né loro acconsentirebbero a piegarsi alle compostezze dell’english etiquette... Il fatto è che il piccolo Cedric – sempre rosso per l’emozione, sempre allegro e rispettoso, sempre sorridente e saltellante, sempre con i suoi lucenti golden curls da Shirley Temple ante litteram – finisce quasi per irritarci, facendo tornare alla mente (almeno ai lettori italiani) un altro proverbiale ragazzo, dal destino e dalle vicende diversissime ma altrettanto inappuntabile e stucchevole, vale a dire Ernesto Derossi, il primo della classe di Cuore – anzi, «Il libro Cuore» – di Edmondo De Amicis (pubblicato, guarda caso, pochi mesi dopo Little Lord Fauntleroy e salutato da un successo altrettanto plebiscitario in tutto il mondo) dove, anche lì, i differenti (ma questo, a ben guardare, ha davvero poca importanza) “scontri” e “confronti” dell’Italietta postunitaria vengono affrontati in mezzo a dolci sorrisi, gesti generosi e lacrime di consolazione... Quel Derossi, dicevamo, che non sfigurerebbe di certo nei saloni del castello di Dorincourt accanto al vecchio nonno aristocratico, e al quale il titolo di Lord sembra calzare come un guanto, poiché dotato, lui pure, di un perfetto physique du rôle: «grande, bello, con una corona di riccioli biondi, lesto che salta un banco appoggiandovi la mano su; e sa già tirare di scherma»...5
RICCARDO REIM
1 Per le sue illustrazioni (che contribuirono non poco alla fortuna del romanzo) Birch prese come modello Vivian Burnett, secondogenito della scrittrice, che in seguito diverrà la vera e propria “incarnazione” del piccolo Lord Fauntleroy.
2James, nonostante il vero e proprio “corteggiamento” della scrittrice nei suoi confronti, non avrà mai una gran stima della Burnett, considerandola sempre una sorta di parvenu.
3 Con una sorta di curioso – e inquietante – sdoppiamento, Frances Hodgson Burnett da un lato aderirà con ostentazione ai più triti stereotipi della “signora romantica” (ad esempio facendosi chiamare con una serie di nomignoli, storpiamenti e diminutivi quanto mai leziosi se non inopportuni: Mammie, Mammiday, Small Princess, Fuffy, Fluffina, Fluffiana...), mentre dall’altro rivelerà, nella vita pubblica come in quella familiare (due volte sposata e due volte divorziata, ad esempio) un carattere tirannico, sorprendentemente deciso e anticonformista.
4 Vedi a tale proposito Antonio Faeti, Coraggio e poesia della differenza, postfazione a Frances H. Burnett, Il piccolo Lord Fauntleroy, Rizzoli, BUR, nuova ed. Milano 2010.
5Edmondo De Amicis, Cuore, Il primo della classe.
Nota biografica
Frances Eliza Hodgson Burnett nasce in Inghilterra, a Manchester, il 24 novembre 1849 e muore a Plandom (Manhasset, Long Island) il 29 ottobre 1924. Fin da bambina rivelò un grande amore per la lettura, nonché un carattere alquanto indipendente, incline alla fantasticheria e alla solitudine. Subito dopo la morte del padre, nel 1864, la famiglia, in condizioni finanziarie alquanto precarie, si trasferisce negli Stati Uniti, a Knoxville, nel Tennessee. Le cose peggiorano ulteriormente quando le promesse di aiuto da parte di alcuni parenti si rivelano infondate e quando anche la madre, nel 1870, viene a mancare. È così che la diciottenne Frances, dotata di un carattere alquanto deciso e intraprendente, comincia a scrivere regolarmente, anche per far quadrare il magro bilancio familiare: «Godey’s Lady’s Book», «Harper’s Bazaar», «Scribner’s Monthly», «Peterson’s Ladies’ Magazine» sono le riviste che ospitano con puntuale regolarità i suoi primi racconti. Nel 1873 si sposa con il dottor Swan M. Burnett di Washington D.C.
1 comment