Il supermaschio
LDB
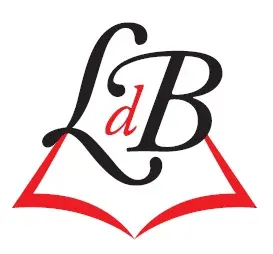
“Il supermaschio, può essere letto in molti modi, tutti assolutamente legittimi. Come sempre in Jarry, anche in questo racconto fantastico c’è tutto (o quasi) e il contrario di tutto.
C’è l’amore non corrisposto dell’uomo per le macchine, e c’è ‘la macchina per ispirare l’amore’. Ci sono le fantasie dell’adolescenza, riassunte nella frase con cui inizia il racconto: “L’amore è un atto senza importanza, perché lo si può fare all’infinito”. C’è la donna, vista dapprima come preda e accettata poi come rivale e come benevola padrona. Ci sono i limiti del Progresso e quelli dell’uomo. C’è la passione di Jarry per gli sport. Ci sono, lontani e sfocati sullo sfondo, il Superuomo di Nietzsche (Così parlò Zarathustra è una delle opere-chiave di quegli anni) e Superman l’eroe dei fumetti (che ancora non è stato inventato ma che ha in André Marcueil un suo precursore).
E c’è perfino, in filigrana, una storia d’amore: perchè no? Una banalissima e comunissima storta d’amore. Chi, almeno una volta nella vita, non si è sentito supermaschio (o superfemmina)? Grande, inimitabile Jarry.”
Dalla Prefazione di Sebastiano Vassalli
Alfred Jarry, drammaturgo, scrittore e poeta, è noto soprattutto come il creatore della maschera grottesca di padre Ubu nell’Ubu re, per poi riprenderla e moltiplicarla nelle successive scritture a lui dedicate: Ubu Cocu, Ubu incatenato, Ubu sulla collina, Almanacco del padre Ubu. Alla sua visionarietà sovvertitrice si ispirò Antonin Artaud, che nel 1926 fondò il Teatro Alfred Jarry.
Della propria vita di letterato, consumatore di assenzio, appassionato di sport e fondamentale misogino, creò un mito. Tra gli altri scritti di Jarry, I minuti di sabbia. Memoriale, i romanzi L’amore assoluto e Messalina, gli scritti giornalistici Speculations e Gestes.
NARRATORI STRANIERI

ALFRED JARRY
IL SUPERMASCHIO
Traduzione e Postfazione di Giorgio Agamben
Prefazione di Sebastiano Vassalli
ROMANZO
BOMPIANI
Jarry, Alfred, Le Surmâl
© 1967 / 2012 Bompiani / RCS Libri S.p.A.
Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano
ISBN 978-88-58-75344-6
Prima edizione digitale 2012 da edizione Bompiani settembre 2012
Copertina: progetto grafico Polystudio


Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
Alfred Jarry nasce a Laval, in Bretagna, l’8 settembre 1873: due anni e mezzo dopo la Comune di Parigi e nei giorni stessi in cui l’Alliance Typographique di Bruxelles ha in corso di stampa Une saison en enfer di Rimbaud. Il luogo della nascita forse non è molto importante: più importante è l’anno, per i motivi che dirò e perchè mi permette di confrontare la sua vita con quella dell’altro·grande “irregolare” della letteratura francese dell’Ottocento: da cui tutto, nelle opere, sembra dividerlo e con cui però ci furono strane affinità di percorso. Come Rimbaud, infatti, Jarry nasce in una città di provincia; al liceo è uno studente per molti versi esemplare, un “primo della classe”; va, giovanissimo, a Parigi dove entra in contatto con l’ambiente artistico-letterario e dove vive in maniera sregolata (André Breton lo definirà “un surréaliste dans l’absinthe”, un surrealista sotto assenzio); muore giovane, a trentaquattro anni, (Rimbaud era morto a trentasette). Un altro elemento comune, abbastanza sorprendente, è la conversione di entrambi alla fede. Che per Rimbaud si compie sul letto di morte ed è testimoniata dalla sorella e che anche per Jarry rappresenta un approdo degli ultimi tempi, certamente serio e attendibile anche se argomentato in modo quasi “patafisico”: “Credo quia absurdum… non credere”, credo perchè sarebbe assurdo, per me, non credere. L’affinità più vistosa tra i due scrittori, però, è data dal fatto che al centro delle vite di entrambi ci sono gli anni dell’adolescenza. L’adolescenza è il punto di riferimento obbligatorio per l’opera di Jarry come per quella di Rimbaud, e fa sì che possano esistere nei loro confronti due livelli interpretativi diversi se non addirittura opposti, uno molto complesso e l’altro molto semplice. Per fare un esempio, le famose “lettere del Veggente” di Rimbaud, per cui si sono volute tirare in ballo l’intera storia della letteratura e quella della filosofia, con aggiunta (a piacere) di religioni, psicologie e scienze dell’occulto, possono anche essere lette più semplicemente come repertori di luoghi comuni adolescenziali, di un liceale che, in seguito alla chiusura delle scuole per via della guerra franco-prussiana, si diverte a “spararle grosse” scrivendo delle lettere ai suoi professori. E così il personaggio centrale dell’opera di Jarry, il Père Ubu su cui tanto è stato scritto fino a costruirgli intorno un intero sistema filosofico, e che ha cambiato la storia della letteratura e quella del teatro, altro non è che la caricatura di un professore del liceo di Rennes, dove Jarry si trasferisce con la famiglia nel 1888. È lì, a Rennes, che il liceale quindicenne Alfred Jarry mette in scena nel locale teatro delle Marionette uno spettacolo intitolato Les Polonais, che di fatto è l’anticipazione della sua opera più famosa, l’Ubu Roi del 1896, e delle altre opere che seguiranno centrate sul personaggio di Ubu. (La chanson du décervelage, La canzone dello scervellamento, 1899; Petit almanach illustré du Père Ubu, Piccolo almanacco illustrato del Padre Ubu, 1899 e Almanach illustré du Père Ubu (XX siècle), Almanacco illustrato del Padre Ubu (XX secolo), 1901; Ubu enchaîné, Ubu incatenato, 1900; Ubu sur la Butte, Ubu sulla Collina, 1906; Ubu-Cocu, Ubu Cornuto, opera postuma).
Nell’adolescenza di Jarry, come in quella di Rimbaud, ci sono tutti gli ingredienti delle opere che verranno. Ci sono la passione per le armi, soprattutto per le armi da fuoco, e quella per gli sport e per il ciclismo, che sarà uno dei temi centrali anche nel racconto fantastico Le surmâle (Il supermaschio). Ci sono i travestimenti e anche i travestimenti macabri, come quegli “scheletri bianchi su fondo nero che giocano al chiar di luna” che lui, a Rennes, si divertiva a dipingere sulle pareti della sua cameretta, secondo la testimonianza della sorella Charlotte.
Dopo avere passato in rassegna le somiglianze tra Jarry e Rimbaud, bisogna però dire qualcosa delle diversità: che ci furono e furono notevolissime, non soltanto nelle opere ma anche nei caratteri e nelle scelte di vita. Anche se vale per entrambi l’osservazione di André Breton, che “la differenza ritenuta per lungo tempo come necessaria, tra l’arte e la vita, si trova ad essere contestata fino a venire annientata nel suo principio”. Arte e vita, per entrambi, coincisero; ma le personalità furono molto diverse. Jarry, all’opposto di Rimbaud, volle essere “personaggio” e lo volle consapevolmente, se è vero che considerava rappresentazioni teatrali anche i suoi scandali costruiti ad arte per strada o nei locali pubblici, e che poi chiedeva a chi vi aveva assistito: “Era della buona letteratura, non credete anche voi?” Ma per dare un’immagine viva e credibile dell’uomo Jarry è meglio cedere la parola a uno scrittore suo contemporaneo, che ebbe modo di conoscerlo e di paragonarlo a un Cobold, cioè a un folletto:
“Questo Cobold,” scrisse André Gide nel 1940, “dalla faccia biancastra, dall’acconciatura da circo, e recitante un personaggio fantastico, costruito, decisamente fittizio e all’infuori del quale più nulla di lui si mostrava, esercitava a quei tempi una sorta di fascino singolare. Tutti coloro che lo circondavano si sforzavano, con maggiore o minore successo, di imitare, di adottare il suo humour e, soprattutto, la sua bizzarra implacabile elocuzione, priva di inflessioni o sfumature, con eguale accentuazione di tutte le sillabe, ivi comprese le mute. Se uno schiaccianoci avesse parlato, non avrebbe potuto fare altrimenti. I surrealisti, in seguito, non inventarono niente di meglio, ed è sotto questo titolo che essi riconobbero e salutarono in lui un precursore […].
Di fronte a Jarry, gli altri habitués dei salotti di Rachilde (Rachilde Vallette, moglie del direttore del “Mercure de France”) facevano, ai miei occhi almeno, la figura di comparse.”
C’è una vasta aneddotica su Jarry che riguarda, oltre al suo modo bizzarro di parlare, le sue tenute da cavallerizzo, o da schermitore o da ciclista, le sue camicie di carta con le cravatte disegnate in inchiostro di china, le sue esibizioni in pubblico con il revolver (celebre la risposta a una signora infuriata che lo rimproverava: “Potevate uccidere i miei figli!”, “Eh, signora, ve ne avremmo fatti degli altri”), la sua ultima richiesta prima di morire all’amico dottor Saltas (il “merdecin” che lo curava): “Datemi uno stuzzicadenti”. Gli anni di Alfred Jarry a Parigi, dal 1890 fino alla morte avvenuta nel 1907, furono gli anni della cosiddetta “belle époque”: quando Parigi era il centro della cultura europea e l’Europa era il centro di un mondo ancora in parte sconosciuto e dunque, in qualche misura, infinito.
1 comment