Il Tempo ritrovato
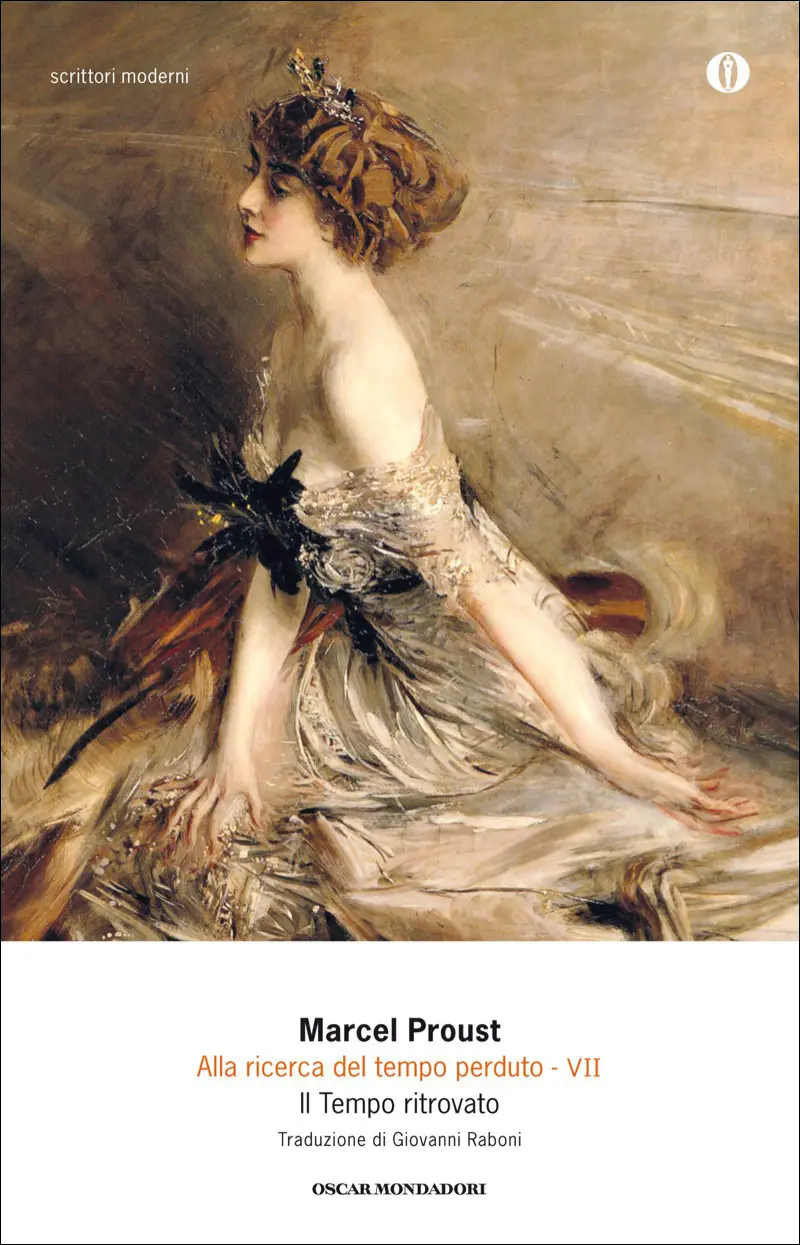
Il libro
Capitolo conclusivo della Recherche du temps perdu, Il Tempo ritrovato (1927) getta sull’intera opera una luce retrospettiva che dà senso e valore a tutti gli episodi narrati, anche a quelli che potrebbero sembrare “tempo sprecato”. In una Parigi e in una Combray che non sfuggono alla distruzione bellica, il Narratore compie le esperienze decisive, fino a scoprire, grazie a una semplice pietra sconnessa, il ruolo fondamentale delle memorie involontarie e, con esso, la propria vocazione letteraria: la narrazione torna così a chiudersi sul proprio inizio, celebrando la vittoria dell’arte sul Tempo e sulla morte.
L’autore
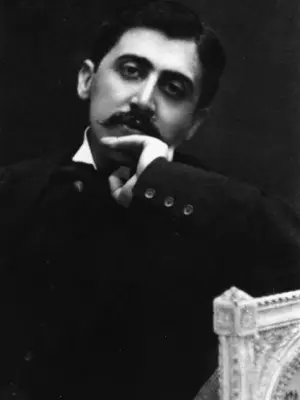
Marcel Proust è nato nel 1871 a Parigi, dove è morto nel 1922. La sua fama è legata all’imponente romanzo Alla ricerca del tempo perduto, suddiviso in sette libri, al quale si è dedicato per tutta la vita e che venne pubblicato, in parte postumo, a partire dal 1913.
di Marcel Proust
ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO
Dalla parte di Swann
All’ombra delle fanciulle in fiore
La parte di Guermantes
Sodoma e Gomorra
La Prigioniera
Albertine scomparsa
Il Tempo ritrovato
Un amore di Swann
Le lettere e i giorni
Marcel Proust
ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO
VII
IL TEMPO RITROVATO
Traduzione di Giovanni Raboni
Introduzione di Alberto Beretta Anguissola

NOTA INTRODUTTIVA
di Alberto Beretta Anguissola
L’Introduzione generale di Luciano De Maria, la cronologia a cura di Luciano Erba e la bibliografia essenziale sono pubblicate nel primo volume di questa serie: M. Proust, Alla ricerca del tempo perduto, I, Dalla parte di Swann, Oscar Mondadori 2012.
La prima domanda che potremmo porci, accostandoci a questo ultimo libro della Ricerca, è: “Dove finisce Albertine scomparsa e dove comincia Il Tempo ritrovato?”. Rispondere non è affatto facile.
Durante gli anni della guerra, pur continuando a inventare nuovi sviluppi e nuovi personaggi, Proust si dedicò a redigere, in venti quaderni contraddistinti con cifre romane, una sorta di “bella copia” (mise au net) di tutta quella parte del romanzo che va da Sodoma e Gomorra compreso alla conclusione, selezionando gli esiti migliori tra le stesure dei vari episodi sparse qua e là nei quaderni di abbozzi. Questo lavoro, già terminato nel 1918, proseguì poi con molte aggiunte fino alla morte, nel 1922.1
Il testo incluso in questo volume è contenuto in sei di quei quaderni, dall’ultima parte del quindicesimo al ventesimo. In corrispondenza del punto di inizio adottato in questa edizione (identico a quello scelto per la prima edizione postuma del 19272 e per la nuova Pléiade del 1989) manca però, nel manoscritto, un chiaro segno di divisione con l’indicazione del nuovo titolo. C’è soltanto uno dei molti fogli lasciati in bianco per eventuali aggiunte.
Si può quindi dedurre che il criterio di separazione usato nel 1927 fosse basato soprattutto su convenienze editoriali. Se invece volessimo individuare e rispettare le “vere” intenzioni dello scrittore, potremmo tentare di ragionare sulla corrispondenza tra il titolo e i temi trattati, e poiché nella mente di Proust Albertine scomparsa faceva ancora parte dell’ampio ciclo di Sodoma e Gomorra,3 si potrebbe pensare che tale titolo si riferisca anche alle pagine che narrano le gesta tragicomiche di Charlus durante la guerra, bordello gay di Jupien compreso. Se così fosse, il vero e proprio Tempo ritrovato comincerebbe allora con la frase: «La nuova casa di cura in cui mi ricoverai non mi guarì più della prima». Potrebbe forse suffragare questa ipotesi una lettera in cui Proust si sforza di tranquillizzare il virtuoso Daniel Halévy, storico e saggista nonché compagno di liceo di Marcel: «Nei volumi che seguiranno – per esempio dopo la morte di Albertine, nel Tempo ritrovato – il nome di Sodoma (preso peraltro in Vigny) non sarà mai più pronunciato».4 Va nella stessa direzione un annuncio pubblicitario comparso il 1° dicembre 1922 (Proust era morto da appena dodici giorni) sulla «Nouvelle Revue Française»: «In stampa: Sodoma e Gomorra, III. La Prigioniera – Albertine scomparsa. In preparazione: Sodoma e Gomorra in parecchi volumi (seguito) – Il tempo ritrovato (fine)». Se questa anticipazione rispecchiasse le ultime volontà dello scrittore, sarebbe evidente che tra Albertine scomparsa e il Tempo ritrovato erano previste altre sezioni intitolate anch’esse Sodoma e Gomorra, magari con l’aggiunta di qualche sottotitolo per non confondere il lettore.
Samuel Beckett sostiene che il titolo “Il Tempo ritrovato” sia inadatto per la cosiddetta “Adorazione perpetua” (la parte incentrata sulla vittoria dell’arte sul Tempo e sulla morte) e possa corrispondere in modo pertinente soltanto al bal de têtes (le ultime centotrentacinque pagine del romanzo, con la scoperta del trionfo del Tempo e la visione di tutti i personaggi sfigurati dalla vecchiaia).5 Questa sua intuizione trova riscontro in un annuncio riguardante le successive parti del romanzo che era comparso nella prima edizione di All’ombra delle fanciulle in fiore, nel 1918. Vi leggiamo: «M. de Charlus durante la guerra: le sue opinioni, i suoi piaceri – Ricevimento dalla principessa di Guermantes – L’adorazione perpetua – Il Tempo ritrovato».
Nessuna scienza è meno esatta della filologia. Non mancano infatti buoni argomenti per sostenere la tesi opposta. Quando, nel 1913, uscì l’edizione Grasset di Dalla parte di Swann, vi erano descritti sommariamente i volumi successivi. Il Tempo ritrovato sarebbe stato il terzo volume e avrebbe compreso numerosi episodi assai eterogenei tra loro: «All’ombra delle fanciulle in fiore – La principessa di Guermantes – M. de Charlus e i Verdurin – Morte di mia nonna – Le intermittenze del cuore – I vizi e le virtù di Padova e di Combray – Madame de Cambremer – Matrimonio di Robert de Saint-Loup – L’adorazione perpetua». Se ne potrebbe dedurre che, tutto sommato, Proust attribuisse un’importanza relativa alla corrispondenza tra titolo e argomento. Un titolo era per lui qualcosa di elastico, dilatabile e fluttuante. E così il problema resta aperto.
Il Tempo ritrovato: molto dipende da quale significato attribuiamo a questo titolo. Ne intravedo almeno tre: 1) la resurrezione del “vero” passato nella memoria involontaria; 2) l’accettazione della propria esperienza vissuta di cui si riconoscono (si “ritrovano”) retroattivamente il significato e il valore, giacché anche gli episodi in essa più inautentici (il tempo sprecato) sono stati tappe preziose nella realizzazione della «vocazione»; 3) il rifiuto delle filosofie che negano l’importanza del Tempo e in particolare il superamento del “sistema” di Schopenhauer.
Vale la pena di ricordare, a proposito di quest’ultimo punto, che il filosofo tedesco, adorato a suo tempo dal giovane Proust, aveva sostenuto che l’uomo saggio «non crederà più, come fa l’uomo del volgo, che il tempo possa generare qualcosa di veramente nuovo e di veramente importante», né come accrescimento né come distruzione di valori. Ogni visione storica, sia sul piano collettivo sia su quello individuale, è ingannevole poiché «si riduce ad assumere (come se Kant non fosse mai esistito) che il tempo sia una determinazione della cosa in sé».6 Del resto che la simpatia di Proust per Schopenhauer fosse diminuita negli ultimi anni basterebbe a dimostrarlo il fatto che nel Tempo ritrovato a Madame de Cambremer, una snob sempre schiava delle penultime mode, è assegnato il ruolo di propagandista del pensiero di questo filosofo: «Rileggete quello che Schopenhauer dice della musica».
Già, la musica! Più volte, a proposito di Wagner o di Vinteuil, il Narratore aveva meditato sul fatto che la musica gli «sembrava qualcosa di più vero di tutti i libri conosciuti», perché, a differenza della letteratura, costretta a servirsi di concetti sempre un po’ astratti, i suoni possono «prendere l’inflessione dell’essere, riprodurre la punta interiore ed estrema delle sensazioni» (La Prigioniera, in altre parole: possono costituire un equivalente di quello che Schopenhauer aveva battezzato “Volontà”. E quando tra il 1910 e il 1911 Proust scrive, nei quaderni 58 prima e 57 poi, un’ampia versione della “Matinée chez la Princesse de Guermantes”, immagina che agli invitati sia offerto l’ascolto del celebre Incantesimo del Venerdì Santo dal Parsifal di Wagner, detestato, perché troppo schopenhaueriano, troppo “decadente” e troppo “cristiano”, dal Nietzsche del Caso Wagner.7 Sennonché, tra il 1913 e il 1916, sempre sul Cahier 57, lo scrittore registra vari spunti per questa parte del romanzo, dai quali si capisce che è incerto tra il mantenere al posto d’onore l’ultimo capolavoro di Wagner oppure sostituirlo con un Quartetto dell’immaginario Vinteuil, meno schierato ideologicamente. E non finisce qui. Questo Quartetto si trasformerà in Settimino e sarà “retrocesso” nella Prigioniera, in modo che, alla fine, il ritrovato valore della letteratura non sia offuscato dal confronto con la musica. Scarsa importanza viene attribuita ai brani musicali che, nella versione del manuscrit au net, sono eseguiti durante il ricevimento della nuova principessa di Guermantes (Proust nomina solo la beethoveniana e tolstoiana Sonata a Kreutzer).
1 comment