Racconti fantastici
I GRANDI LIBRI
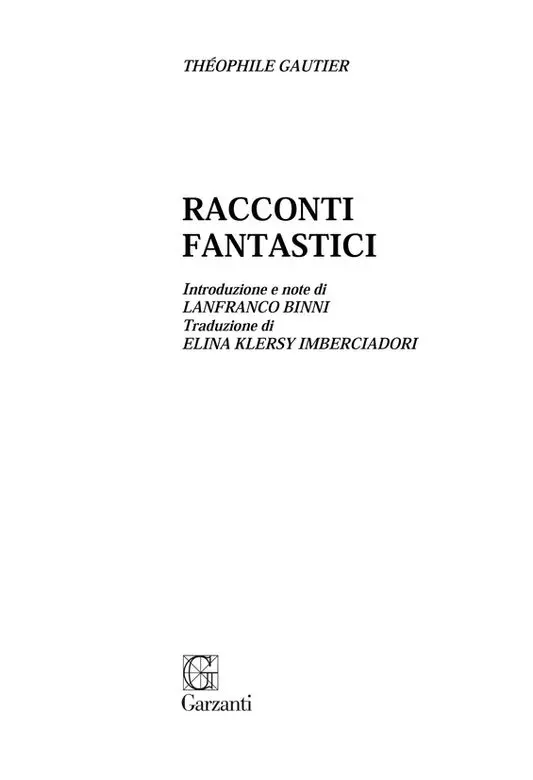
Traduzione dal francese di
Elina Klersy Imberciadori
Titolo originale dell’opera:
Récits fantastiques
In copertina: Fedra di Alexandre Cabanel (1880).
Montpellier, Musée Fabre.
ISBN 978-88-11-13262-2
© Garzanti Editore s.p.a., 1993
© 2006, 2011, Garzanti Libri s.p.a., Milano Gruppo editoriale Mauri Spagnol
www.garzantilibri.it
Per essere informato sulle novità del Gruppo editoriale Mauri Spagnol visita il sito www.illibraio.it
Prima edizione digitale 2011
Realizzato da Jouve
Quest´opera è protetta dalla Legge sul diritto d´autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
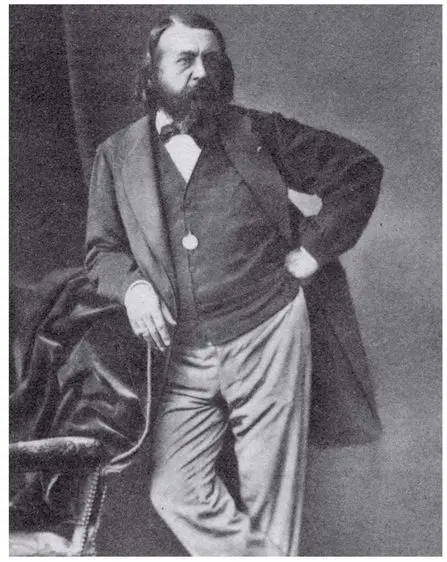
Théophile Gautier in una foto del 1857ca.
INTRODUZIONE
La vita e le opere
Ammirato dai poeti e a lungo disprezzato dai critici, Gautier, il romanziere di Mademoiselle de Maupin e del Capitaine Fracasse, il poeta di Albertus e di Emaux et Camées, il librettista di Giselle, il critico letterario e d’arte della «Presse», del «Moniteur universel» e di tante altre riviste, il narratore ‘fantastico’ della Cafetière e di Spirite, è ancora oggi prigioniero di immagini comunque parziali. La recente rivalutazione del narratore fantastico rispetto al poeta e al romanziere, se condotta con povertà d’idee e unilateralità non contribuisce certo a rendere giustizia a uno dei protagonisti della letteratura europea tra 1830 e 1870. «Un uomo sconosciuto» lo definì Baudelaire in un celebre saggio del 1859 sul «grande poeta» cui aveva dedicato due anni prima Les Fleurs du Mal. Sconosciuto nella complessità della sua poetica e nella genialità della sua arte, nella sua contraddittoria ma infaticabile fedeltà all’ ‘idea fissa’ di un linguaggio compiutamente espressivo e vivo di vita propria, capace di creare universi liberati da sordide impurità quotidiane: una ricerca costellata di pietre preziose, androgini inquietanti, classiche bellezze, irregolarità barocche, estetismo ed erotismo, audaci tentativi di resistere alla morte deragliando dai suoi binari il carro del tempo e dello spazio. Ma soprattutto sconosciuto creatore di una poetica (e di opere) fortemente unitaria, coerente, autonoma dai valori e linguaggi della società dei droghieri, del ‘progresso’ capitalistico e del dominio delle cose sugli uomini.
L’infanzia a Tarbes e a Parigi
Pierre-Jules Théophile Gautier nasce a Tarbes, piccolo villaggio degli Alti Pirenei, alla frontiera con la Spagna, il 30 agosto 1811. Suo padre, Jean-Pierre Gautier, nato nel 1779 in una famiglia di proprietari fedele alla monarchia, è impiegato al catasto; nel 1810 ha sposato una giovane borghese, Antoinette-Adélaide Cocard, la cui famiglia gode della protezione dei conti di Montesquiou; ed è nel loro castello d’Artagnan che si è celebrato il matrimonio. Théophile trascorre i primi tre anni della sua vita nel paesaggio assolato, luminosissimo, di Tarbes; lì, tra colori abbaglianti e sapori forti, si forma la sua sensibilità di meridionale. Nel 1814, alla caduta dell’Impero, Jean-Pierre Gautier si trasferisce con la famiglia a Parigi; grazie alla protezione dei Montesquiou ha ottenuto un impiego nella capitale, presso l’ufficio del dazio; contemporaneamente curerà gli affari di Xavier de Montesquiou, futuro ministro degli interni nel periodo della Restaurazione. Dal sole di Tarbes alla nebbia e al grigiore di Parigi: il trasferimento apre nella sensibilità di Théophile una prima ferita, che assai presto si trasformerà in mitica nostalgia dei luoghi e delle sensazioni della prima infanzia; l’adolescente si sentirà straniero, come «un piccolo spagnolo di Cuba, pieno di nostalgia, mandato a educarsi in Francia». E, pur amato e protetto dai suoi anche dopo la nascita delle sorelle Emilie e Zoè, inizierà assai precocemente a sperimentare personali evasioni in altri universi, attraverso ingegnosi spettacoli di burattini rappresentati davanti al pubblico delle due sorelle, e soprattutto attraverso la lettura. Con i burattini, con i viaggi della fantasia e delle parole, si costruisce degli ‘altrove’ in cui ogni nuova avventura diventi possibile.
Fino agli undici anni studia in casa sotto la guida del padre; molte letture, sempre più impegnative: da Walter Scott a Shakespeare, a Byron. Nel 1822 viene iscritto come interno al liceo Louis-le-Grand; ma non sopporta la vita di collegio, e dall’ottobre dello stesso anno segue da esterno i corsi del liceo Charlemagne. Lì si forma una rigorosa educazione umanistica, una solida cultura classica che lo porrà in grado di misurarsi con le tensioni culturali e politiche della società francese alla vigilia della rivoluzione del 1830. È sui banchi del liceo Charlemagne che incontra un amico determinante per il suo percorso intellettuale: Gérard Labrunie, il futuro Gérard de Nerval, uno dei protagonisti della nuova cultura romantica. Attraverso Nerval, che dal 1826 comincia a pubblicare versi e articoli, e lo inizia alla conoscenza del romanticismo tedesco e del Faust di Goethe che sta traducendo, Gautier entra rapidamente nell’ambiente straordinariamente vivace, irregolare, anticonformista, dei romantici incendiari alla Pétrus Borel. Nel 1829 inizia a frequentare lo studio del pittore Rioult; avverte un’attrazione irresistibile per la pittura e per le arti figurative, e considera il linguaggio pittorico complementare del linguaggio letterario; è deciso a praticarli entrambi con l’obiettivo di sperimentare linguaggi nuovi, capaci di esprimere l’inesprimibile. In questo stesso anno Nerval e Borel lo presentano a Victor Hugo, che da molti anni Gautier considera il maestro dei maestri; l’incontro è decisivo: Gautier abbandona lo studio della pittura e si getta nella «battaglia romantica» da poeta.
La «battaglia romantica»
Alla vigilia della rivoluzione del luglio 1830 essere romantici significa essere rivoluzionari sia in letteratura che nella società. «Il romanticismo», scrive Victor Hugo nel febbraio del 1830, «è il liberalismo in letteratura». Cadono le regole del classicismo, e vengono affermati i diritti dell’assoluta libertà d’espressione e di creazione. È un momento entusiasmante; ricorderanno Gautier e Nerval: «Una linfa di nuova vita circolava impetuosa. Tutto germogliava [...]. Eravamo ebbri di poesia e d’amore [...]. Sognavamo di rovesciare il pianeta». Libertà assoluta nell’Arte, e libertà assoluta nei comportamenti individuali. «Per noi il mondo si divideva in fiammeggianti e grigiastri; ai primi andava tutto il nostro amore, agli altri tutta la nostra avversione. Volevamo la vita, la luce, il movimento, l’audacia di pensiero e di creazione, il ritorno alle belle età del Rinascimento e alla vera antichità [...]. Per noi Diderot era un fiammeggiante, Voltaire un grigiastro, e questo valeva anche per Rubens e Poussin». Pétrus Borel, repubblicano a oltranza, scrive versi contro la canaglia borghese, Gautier porta i capelli ‘alla merovingia’... Ci si sente alla vigilia di cambiamenti epocali, eccezionali, e ogni comportamento è tremendamente decisivo. Nel febbraio del 1830, la battaglia dell’Hernani, lo scontro frontale tra romanticismo e tradizionalismo classicista all’interno di un tempio della cultura e, per quattro giorni, nelle strade di Parigi.
1 comment