Tutte le poesie
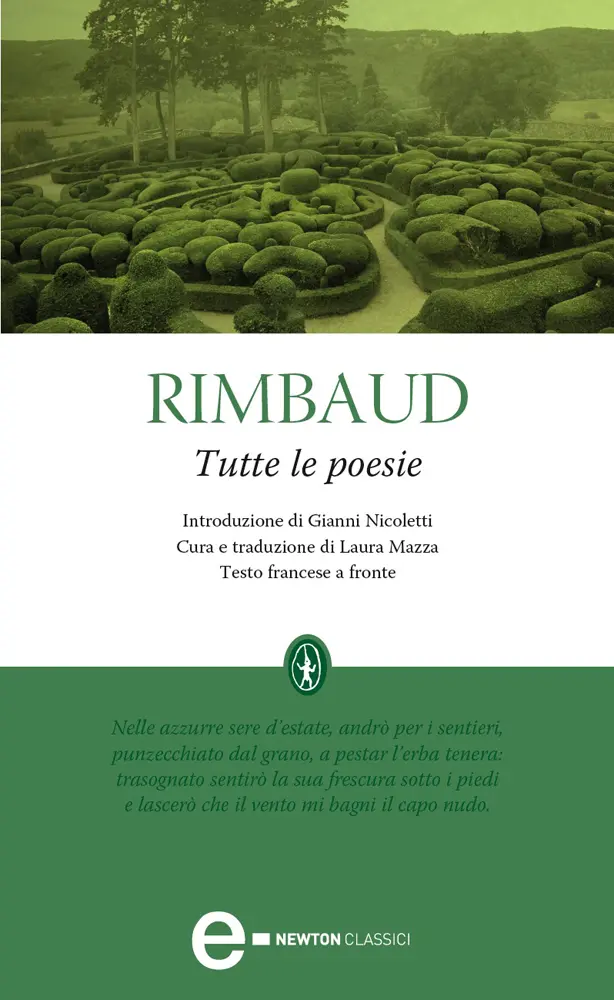
Arthur Rimbaud
Tutte le poesie
Introduzione di Gianni Nicoletti
Cura e traduzione di Laura Mazza
Testo francese a fronte

21
Prima edizione ebook: ottobre 2011
© 1972, 1989, 2007 Newton Compton editori s.r.l.
ISBN 978-88-541-3417-1
www.newtoncompton.com
Edizione digitale a cura di geco srl
Introduzione
La vicenda umana e la poesia di Rimbaud hanno completa e soddisfacente collocazione nel quadro della storia e della letteratura francese dell’Ottocento. Questa che pare verità, se non a tutti incontestabile almeno confortata da buone ragioni, si è fatta faticosamente strada in una selva di gratuiti giudizi, eccessive esaltazioni o larvate calunnie, di una critica fino a pochi decenni or sono incapace di dare una sistemazione alla sua opera. Se ne vedeva soprattutto, con passione, la dismisura sfuggente e ambigua, e vi concorrevano una biografia mal nota e i testi considerati spesso, e senza sforzo, incomprensibili; si ripetevano luoghi comuni, notizie inesatte, formule stanche ma di effetto come quella di «mistico allo stato selvaggio», deducendo da dommatiche convinzioni; si accentuava il carattere di estraneità alla scrittura propriamente detta, lo straordinario tentativo di fare poesia al di là della poesia, o poesia «metafisica»; si spiegavano pretese scelleratezze con la subdola definizione di «angelo decaduto» o con insinuazioni, di origine vagamente lombrosiana, su vizi psicologici o fisiologici. Rimbaud veniva così a trovarsi al di fuori del purgatorio della storia letteraria, in un empireo o un inferno, a seconda della bontà o della irritazione di sottili esegeti: era nella ipotesi migliore una eccezione, nella peggiore un caso clinico.
Pure, quest’opera il cui interesse non cessa di dare occasione a indagini e ripensamenti, perfino a filmistiche invenzioni, nasce tutta intera, intensa e breve, fra il 1870 e il 1878 circa, dalle complesse vicissitudini di una letteratura secondo una certa prospettiva ancora mal conosciuta, che da oltre un secolo si tormentava intorno ai medesimi problemi: quale fosse il posto dello scrittore, del poeta e quindi dell’uomo, nella società che andava formandosi, e quale la funzione del linguaggio privilegiato, la stessa scrittura poetica, nella babilonia sorta dalla rivoluzione e che la rivoluzione, talvolta senza volerlo, aveva provocato. Da Rousseau a Senancour, da Chateaubriand a Lamartine, da Musset a Vigny, da Gérard de Nerval a Baudelaire e al copioso e grandissimo Victor Hugo, il cosiddetto romanticismo, con il corteggio del preromanticismo, del tardo romanticismo, del Parnasse e del simbolismo, premeva in un’unica direzione, ad affermare un primato assoluto della espressione lirica. E se la poesia non otteneva il richiesto riconoscimento, o se nei momenti cruciali i poeti non si sentivano bene accetti a quella borghesia da cui erano stati prodotti ma di cui non condividevano né l’arrivismo economico né il materialismo opportunista, era una buona occasione per chiudersi in una ermetica torre di avorio, dalla quale il poeta non voleva e non poteva uscire. Nel gran cumulo delle disillusioni andò formandosi una nuova facoltà della mente, autonoma, isolata, purificata dalle infiltrazioni delle circostanze, che si chiamò meditazione o «rêverie» nel Settecento e nel primo Ottocento, poi «rêve», sogno del tutto libero dalla realtà, causa ed effetto insieme di quella che i francesi dicono «imagination» e che da noi è detta, anche crocianamente, fantasia: una facoltà esente da compromessi, creatrice di oniriche evasioni, spesso alla ricerca di strumenti sollecitatori come le spezie eccitanti di Senancour o il paradiso artificiale di Baudelaire. Se l’istinto messianico dei romantici non poteva avere sbocco, per l’ottusa resistenza della società borghese, meglio era effettuare la sortita nel meraviglioso inesistente, e perdersi in ineffabili amori e morti.
Ma un fatto è di particolare rilievo: che se per un poeta la vita è un tessuto di parole, se il mondo è mondo di parole, una completa e irreversibile sortita in un meraviglioso inesistente per la sua stessa inesprimibilità implicava il grave rischio di un annullamento del linguaggio. Lo avevano capito i preromantici del Settecento, che al culmine della dialettica meditativa ponevano la «uscita» del frequente svenimento, e Rousseau per il quale la suprema «rêverie» poteva essere la morte; Senancour aveva in analoghe situazioni lodato la spericolata solitudine dell’alpe ghiacciata e la felicità di una vita «oscura», e Baudelaire invocò, sul finire delle Fleurs du Mal e dopo lunga altalena tra lo «spleen» e l’«idéal», la morte «vieux capitaine». L’alea di una necrosi del linguaggio poetico derivava dalla impossibilità, impotenza o sfiducia, di poter modificare l’esistente mondo reale, per cui, quasi rimbalzando su di esso e rifiutandolo, la fantasia «creatrice» saliva a rifugiarsi in un ideale assoluto. A forza di successive sperimentazioni il taglio dalla realtà fu sempre più profondo, inciso fino a liberare l’universo fantastico da ogni legame, specialmente da ogni vincolo sociale. Il lirismo romantico ha questa preminente motivazione. E per essa risulta un fatto unico, nella storia della poesia di ogni luogo e tempo, non sacrale, ritualistico, religioso, o petrarchesco, con un almeno implicito rimando a una Beatrice stilnovista illuminata da Dio, ma canto irrimediabilmente scisso, festa metaforica che è fine e principio di se medesima. C’era da chiedersi quanto potesse durare un linguaggio che pretendeva di essere l’unico tutto, e fino a essere l’unico niente, il perfetto mutismo di un silenzio arcano.
Che l’alternativa fosse questa, prosaismo nella realtà o lirica morte per estenuazione, Rimbaud giovanetto (diciassett’anni) lo aveva già capito con la sua prima poesia di rilievo, il Bateau ivre. Era maturato in fretta, con una intensa frequentazione di poeti latini, poi di poeti francesi, studiando per obblighi scolastici o liberamente con l’aiuto del suo giovane insegnante Izambard. Aveva esordito, sensibile e parnassiano, mandando tre poesie a Banville, il 24 maggio 1870, che naturalmente non erano state pubblicate. Ma quando scoppiò la guerra, che doveva presto investire la sua terra natale, le Ardenne, si scoprì più che esperto retore uno sdegnato polemista, feroce satirico, antimilitarista, spregiatore di preti e borghesi, rivoluzionario, infine comunardo e – intendi nella prospettiva del tempo – comunista. Rilevante è appunto questo, che mentre i maturi confratelli, Victor Hugo compreso, già rivoluzionari nel quarantotto, dinanzi al movimento comunardo, si irrigidivano con sospetto e talvolta con aperto disprezzo, Rimbaud rischiava un impegno totale, raggiungendo forse più volte Parigi e scrivendone l’epopea sanguinosa. Cioè Rimbaud credette fermamente in una modificazione della realtà e nella funzione che proprio lui, poeta nuovo ma sempre di estrazione romantica, avrebbe avuto in consegna dal rinato giacobinismo; per cominciare, esigeva dalla rivoluzione molto di più di un nuovo ordine sociale1, un completo capovolgimento, una catastrofe in cui perissero industriali, principi, senati, potenza, giustizia e storia2. E invece, con la settimana di sangue tra il 21 e il 27 aprile, con almeno ventimila esecuzioni e trentottomila arresti, l’insurrezione fu domata. La speranza di fare della realtà poesia era irrimediabilmente perduta.
Cominciò così un penoso itinerario poetico per sfuggire al dilemma esistenziale tra mondo che è e un impossibile modo ideale di essere. Cominciò l’indomani della sconfitta comunarda, mentre «les colères folles» lo spingevano ancora verso Parigi «où tant de travailleurs meurent pourtant encore»3, scrivendo Le Cœur supplicié e la cosiddetta «lettre du voyant». Proseguì in quattro tappe successive, il Bateau ivre, i Derniers Vers, Une Saison en Enfer e le Illuminations. Poi approdò all’arida riva, al fatale distacco dalla poesia, il silenzio.
Secondo la più probabile cronologia, aveva ventiquattro anni.
La lettera a Izambard del 13 maggio 1871, in cui è inclusa la poesia Le Cœur supplicié4, e la lettera «del veggente» del 15 maggio a Paul Demeny costituiscono quindi l’avviarsi dell’esperienza di Rimbaud, il cui primo frutto fu il Bateau ivre. Non è difficile comprenderne i termini, ma a condizione che non si pensi ancora alla «lettre du voyant» come a una teoria estetica invece che come a una tumultuosa presa di coscienza del modo di superare la «impasse» creativa nella quale era venuto a trovarsi.
La lettera del 15 maggio, insieme a quella a Izambard che in parte la completa, è appunto la confessione di un momento commosso con il quale il poeta cerca di recuperare il terreno perduto con la disfatta dell’ideale politico, sia facendo una rudimentale contestazione della cultura francese, sia affermando un nuovo principio: la poesia non deve seguire ma «precedere» l’azione, guidandola per «moltiplicare» il Progresso; il compito del poeta è di «far ascoltare» le sue invenzioni in quanto «chargé de l’humanité, des animaux même»5. Ne deriva un impegno di assoluta oggettività – «JE est un autre» – la cui formula, per quanto espressa in eccesso ellittico, neppure è una novità, e ha un sicuro precedente in Baudelaire che aveva già parlato del poeta attivo e fecondo se riesce a trarre dagli «altri» la singolare ebbrezza di una comunione universale6. Ne deriva pure che se il poeta deve farsi eroe di uno spirito capace di associare e consociare in sé uomini e cose, ha necessità di accettarne e sperimentarne anche il dolore – è la parte più discussa della lettera – realizzando in sé ogni forma di sofferenza, la quintessenza di ogni veleno, diventando il «grande malato», il «gran criminale», il «gran maledetto». Che dice? Dice che per farsi «voyant» il poeta deve attuare una gnoseologia della sofferenza, una sorta di corale supplizio interiore, ed essendo per sempre un reprobo di fronte alla società che aveva stroncato le sue speranze comunarde, Rimbaud non placava la sua «collera» ma vi attribuiva un nuovo significato. Per questo dichiara di volersi imporre un «ragionato sregolamento di tutti i sensi», che equivale a uno sregolamento di tutti i «significati» sia in base all’ambiguità della parola «sens» che per le conseguenze di un alterarsi delle percezioni, paralizzando il lettore «borghese» con l’esorcismo della rivolta permanente e lo scompiglio portato nella realtà di fatto. Il poeta nuovo si limitava a porsi in condizione di passività, dando appena un «colpo di archetto» perché una qualsiasi «regola» lo avrebbe ricondotto nella schiavitù delle categorie tradizionali, e diventando agente provocatore di un capovolgimento, pronto a reinventare l’intero linguaggio.
Quanto al Cœur supplicié, che secondo una ostinata quanto arbitraria tradizione racconterebbe in che modo Rimbaud sarebbe stato iniziato alla sodomia da parte di una non meglio identificata «troupe» di comunardi7, fu invece «la maquette initiale» del Bateau ivre8, e perciò mentre in quello l’io poetico lamenta gli «jets de soupe», in questo, invaso e quasi posseduto dal mare, – dal «Poema del mare» cioè dal mare della poesia – l’acqua «lava» le macchie di vomito. Il Bateau ivre è quindi la grande ripresa poetica dopo la crisi rivoluzionaria, il travagliato ripensamento del Cœur supplicié (si era chiesto: «Comment agir, ô cœur volé?»), e la soluzione della «veggenza», con la quale aveva risposto che il poeta agirà «incaricandosi» dell’umanità, degli animali addirittura. Eppure non è una ripresa risolutiva; la condizione esistenziale del poeta è resa cosciente, ma non modificata. Per questo il Bateau ivre, dopo avere scoperto oceani, linfe inaudite, fosfori canori, Floride, arcobaleni e schiume di fiori, in quel medesimo mare rischia il naufragio. Dopo la «liberazione» espressa dalle prime tre strofe, l’ebbrezza cantata tra la quarta e la diciassettesima, e la catastrofe imminente dalla diciottesima alla ventunesima, la dolente conclusione esclude un ritorno ai percorsi obbligati dei fiumi e dei porti, e rimane la forzata accettazione della «flache», la pozzanghera nera e fredda.
1 comment